
Dal Neolitico a oggi: come è stato coltivato il deserto del Sahara
Uno studio congiunto tra la “Missione Archeologica nel Sahara” di Sapienza, il Department of Antiquities di Tripoli e le università di Milano e Modena-Reggio Emilia indaga antichi metodi di coltivazione, in uso ancora oggi, nelle zone montagnose del deserto più grande del mondo
Siamo abituati a pensare che le uniche zone coltivabili del deserto del Sahara siano le oasi. Forse non è così. E forse lo sapevano addirittura i nostri antenati del Neolitico. Una ricerca, iniziata nel 2005 dalla “Missione Archeologica nel Sahara” di Sapienza, del Department of Antiquities di Tripoli e delle università di Milano e Modena-Reggio Emilia, pubblicata sulla rivista Antiques, ha infatti identificato un sistema agricolo, risalente per l’appunto proprio al Neolitico, che permette di ottenere raccolti di frumento in una delle aree più aride del pianeta.
La zona presa in considerazione dalla ricerca è il Tadrart Acacus nella Libia sud occidentale dove vive la popolazione Tuareg Kel Tadrart. L’area, di circa 5000 km2, è caratterizzata dalla presenza di alcune pozze denominate Ethagas, secche per la maggior parte del tempo, ma in grado di trattenere a lungo acqua e umidità quando si verificano piogge persistenti di particolare intensità. Ed è stata proprio la presenza di queste pozze, secondo gli autori dello studio, a consentire ai nostri antenati di coltivare cereali e verdure nel mezzo del Sahara.
La scoperta è avvenuta per caso: “Eravamo nel deserto per una ricerca sull’utilizzo dell’acqua quando ci siamo trovati al bordo di un avvallamento”, ci racconta Savino Di Lernia, direttore della missione.“Ho chiesto alla nostra guida, Skorta, di cosa si trattasse: è così che le Etaghas sono comparse per la prima volta nel nostro studio”. Gli scienziati ritengono che tali pozze possano comparire ogni cinque o dieci anni; l’ultima di cui si ha traccia risale al 2005. “Con l’ausilio di immagini satellitari capimmo che di Ethagas nella zona ce n’erano tante, ma soltanto quattro, per conformazione e dimensione, hanno sostenuto questa agricoltura montana dei Tuareg”, prosegue Di Lernia. La ricerca etnografica, basata sulla evidenza diretta, sulla memoria degli abitanti del posto e su iscrizioni presenti ai margini delle Ethagas, ha evidenziato uno sfruttamento continuo delle pozze dal diciannovesimo secolo a oggi. Partendo da questi risultati e prelevando campioni in diverse aree si è stabilito, con datazioni al Carbonio 14, un uso agricolo risalente a circa 2000 anni fa.
Ma c’è di più: analizzando le ceramiche e i resti di arte rupestre rinvenuti vicino alle Ethagas si può ipotizzare che lo sfruttamento di questo tipo di agricoltura risalga addirittura al Neolitico, circa 5500 anni fa, quando un cambiamento climatico determinò la fine della cosiddetta “era del Sahara verde” (11000-5500 aC) e l’inizio della fase arida che ancora oggi possiamo osservare. Il risultato della ricerca sul campo è sorprendente: le popolazioni Tuareg di questa zona da millenni utilizzano le Etaghas per coltivare sorgo, orzo e miglio. I raccolti possono arrivare a diverse tonnellate che, per una popolazione di circa 150 persone, rappresentano, oltre che una risorsa alimentare importantissima, anche una merce di scambio.
La dicotomia oasi-deserto viene messa in discussione da questa ricerca: non più una visione oasi-centrica ai cui margini vivono popolazioni nomadi povere in una economia di sussistenza, bensì sistemi interconnessi che hanno uguale importanza e rilevanza. La capacità di coltivare territori desertici ha attraversato i millenni e fa parte dei cosiddetti traditional knowledge che si stanno perdendo nel tempo presente. Se alla parola biodiversità, secondo quanto scritto nella Convenzione sulla diversità biologica di Nairobi del 1992, diamo anche il significato di diversità culturale, si capisce quanto mantenere queste abilità sia importante per il futuro della conoscenza umana. Abilità che possono tornare utili anche alla luce del global warming che sta desertificando ampie zone del pianeta.
La ricerca è stata finanziata dai “Grandi Scavi di Ateneo” di Sapienza Università di Roma e dal Ministero degli esteri e della Cooperazione Internazionale (DGSP – VI).
Immagine Giulio Carcani CC

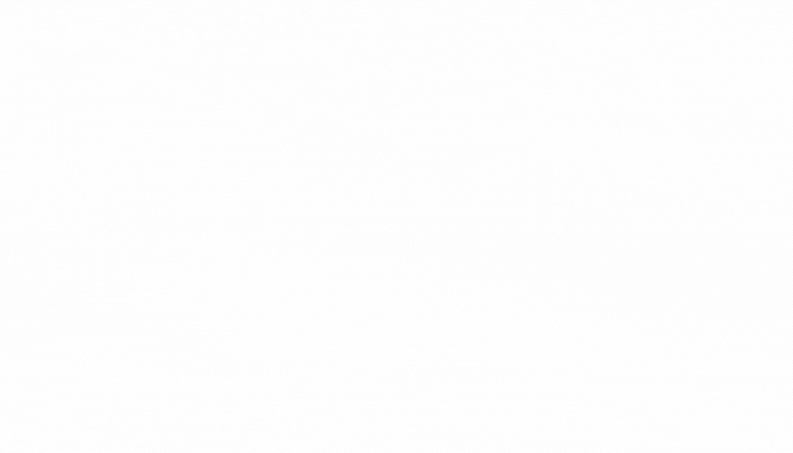
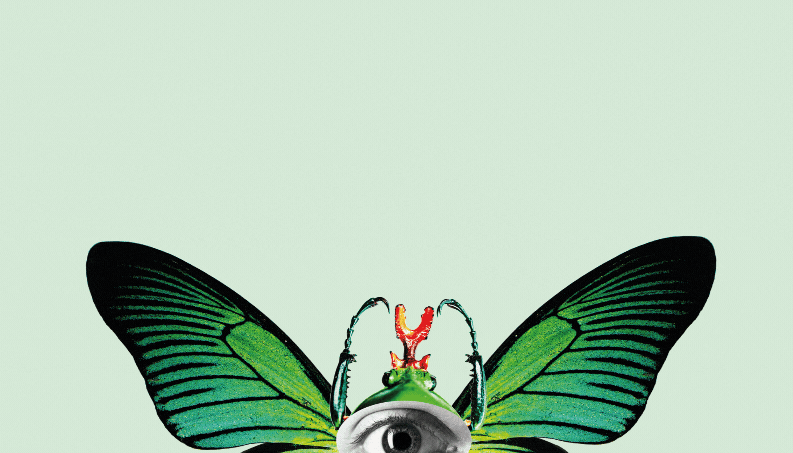



















Commenti recenti