
Immagin arte
Alessandro Penso, fotografo documentarista – come si legge sul suo sito – “motivato dal desiderio di aumentare la consapevolezza sulle ingiustizie ai margini dell’Europa, raffigura coloro che si trovano a subire xenofobia, razzismo e violenza”. Non ne era esattamente consapevole, ma lo abbiamo fermato d’avanti al nostro obiettivo e gli abbiamo strappato un’intervista
Come e perché hai deciso di diventare un fotografo documentarista?
Penso che bisognerebbe indagare la motivazione nella crescita di una persona, in particolare riguardo a cosa ti incuriosisce da quando sei piccolo. Devo dire che la fotografia è arrivata molto tardi nella mia vita. Fino a 26 anni non avrei mai immaginato ci sarebbe stata quest’opportunità, ma ero affascinato dall’idea del lavoro che rappresentava: girare il mondo, conoscere persone, esplorare. E anche a livello romantico: l’idea di combattere per ideali giusti e di raccontare storie di chi ha bisogno di far sentire la propria voce. Queste, erano tutte cose che coincidevano sia con le motivazioni che ho da sempre avuto nella mia testa sia con quello che secondo me è il significato della fotografia. Poi grazie ad alcune congetture astrali ho avuto velocemente la possibilità di studiare e di sopperire alle mie lacune giornalistiche.
Come fai a definire il limite tra farsi completamente coinvolgere dalla storia e restarne un passo indietro?
Essere obiettivi è fondamentale nel mio mestiere e si raggiunge con la maturità. È sempre importante ricordare che non si è custodi di una verità, i punti di vista sono molti e diversi tra loro. Esiste quindi un limite sia professionale che emotivo da non superare. Il primo si impara con il tempo, il secondo è più difficile da gestire perché le storie ti possono coinvolgere davvero tanto e liberarsene è complesso. I sentimenti potrebbero farti vedere le cose in modo diverso e per questo bisogna riuscire a non farli mai interferire con il lavoro. L’obiettivo della macchina fotografica serve un po’ da barriera e oltre a quello esistono regole e strumenti che aiutano a essere più distaccati.
Come riesci a stabilire una connessione con il tuo soggetto?
Se una persona è timida e agitata all’idea di farsi fotografare una buona tecnica è farla ridere, in questo modo si abbassa la tensione e il soggetto appare più rilassato e questo si vede nella postura e nelle espressioni e nelle pose che assume. Al contrario, se abbiamo davanti una persona troppo dominante bisogna contenerla ricordandole che il fotografo sei tu. Non sempre essere un bravo fotografo garantisce un buon lavoro perché possono esserci molte variabili che ti allontanano dall’idea originale e quindi spesso è necessario trovare una soluzione diversa. Il reportage, invece, è completamente diverso perché io non annuncio la foto quando la scatto, devo fare in modo che l’attenzione non sia rivolta a me. Solitamente quello che si fa è andare in anticipo sul luogo dove fotografare per prepararsi nel modo migliore – cosa fotografare, come, quando – perché ognuno ha un proprio punto di vista. Ragionare su cosa raccontare e in che modo è fondamentale affinché il messaggio che vuoi far arrivare sia coerente con il lavoro prodotto.
Nella tua fotografia non c’è morbosità. Osservi da lontano ma trasmetti un messaggio forte. Ti ritrovi in questa definizione?
Oggi, la fotografia non ha bisogno di morbosità. In passato, nella fotografia giornalistica e di reportage, più eri vicino, più potevi catturare quel momento crudele e più eri dentro la storia. Adesso le cose sono diverse. Anche se rimane il bisogno di una documentazione pura penso che poiché tutti possono riprendere quello che accade con il telefono, la domanda che si deve porre un professionista è “che contributo posso dare?”. Fare un passo indietro aiuta proprio a questo: riportare alla natura delle cose, raccontare chi vive queste situazioni senza limitarsi all’evento.
Nel tuo progetto durante la pandemia hai utilizzato il telefonino come mezzo di espressione, riproponendo il classico discorso analogico versus digitale. Come mai la decisione di usare questo strumento?
In generale non penso che lo strumento sia importante. Ognuno è giusto a seconda del progetto che si intende portare avanti. Durante il lockdown ho usato il telefono per raccontare un problema che in Europa stavamo sottovalutando ossia che non tutti potevano stare a casa. Esistevano persone che una casa non l’avevano, o che non era adeguata o anche chi aveva bisogno di lavorare perché non aveva uno stipendio, ma anche chi viveva situazioni pericolose nella propria abitazione e quindi dentro non poteva stare, e io ho voluto darne voce. Ho cercato persone che potessero raccontarci il significato di stare a casa e di essere protetti: dal ragazzo che vive in un campo di rifugiati a una prostituta in Colombia, dall’indigeno dell’Amazzonia a una ragazza italiana di seconda generazione che viveva con altri dieci familiari in una casa senza computer. Volevo raccontare che state a casa non era uno slogan ugualitario per tutti, perché per molti stare nella propria abitazione era qualcosa di veramente difficile. Mostrare il telefono mi ha permesso di enfatizzare questo messaggio: da una parte è il mezzo che mi permette di entrare nelle case delle persone e dall’altro potevamo vivere in prima persona quel racconto.
Hai frequentato la facoltà di Psicologia all’università. Il tuo percorso da fotografo ha attinto da questa materia?
Secondo me lavorare con altre persone, entrare nella loro vita ed essere curiosi sono caratteristiche comuni sia alla fotografia che alla psicologia. Però non credo che studiare psicologia ti faccia diventare un fotografo migliore, penso invece che qualsiasi sia il percorso decidi di intraprendere questo ti porterà da qualche parte. Detto questo, aver fatto psicologia mi ha portato a riflettere su determinate cose, in particolare sul tema della restituzione verso quelle persone che ti hanno aperto il cuore, e che qualcosa se l’aspettano. Questo è poi un mestiere che richiede di essere aggiornato su tante cose, la parte di studio è fondamentale e richiede molto tempo; approfondire ti fa certamente essere un fotografo documentarista più accurato.
Adesso che progetti hai in programma?
Ho iniziato a lavorare sul cambiamento climatico e sto cercando un approccio diverso per proporlo al pubblico. Vorrei raccontare le conseguenze che ha sulle persone e immergere queste ultime in un ambiente che è poi la caratteristica delle mie fotografie, perché mi piace la loro interazione. Poi ovviamente continuo a lavorare sull’immigrazione. Questo è un lavoro dove devi creare domande, incuriosire le persone e creare immagini che diano delle risposte.
Alessandro Penso, fotografo documentarista, vincitore World Press Photo, 2014
Mattia La Torre, biologa e ricercatrice di tipo A presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di Roma
Sofia Gaudioso, biologa e comunicatrice della scienza, Sapienza Università di Roma

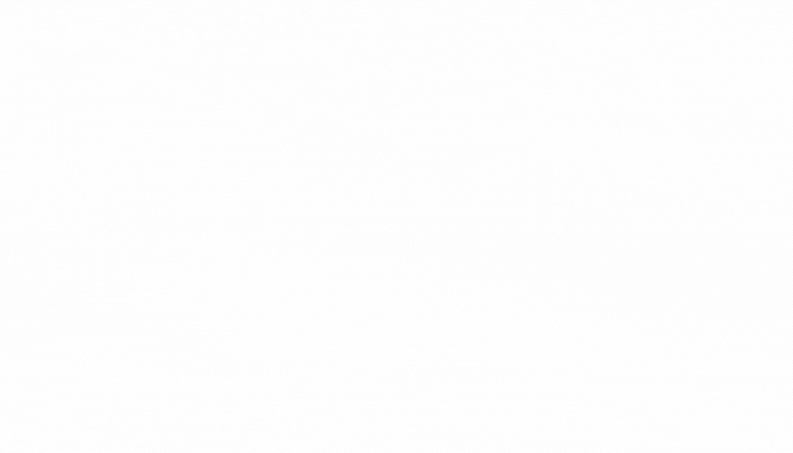
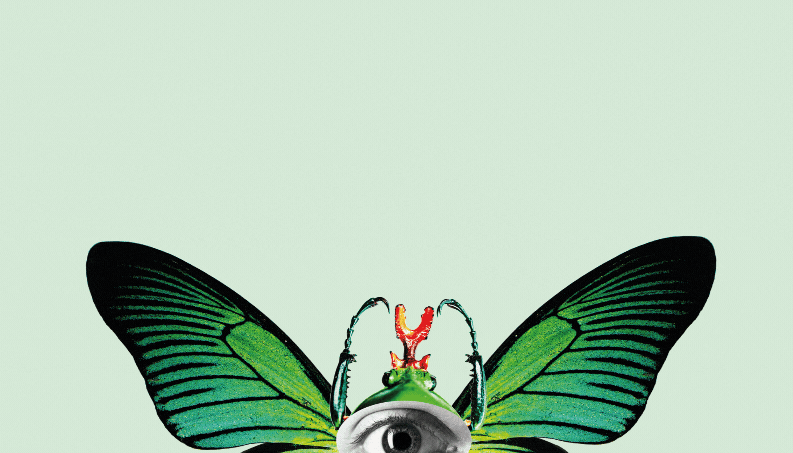


















Commenti recenti