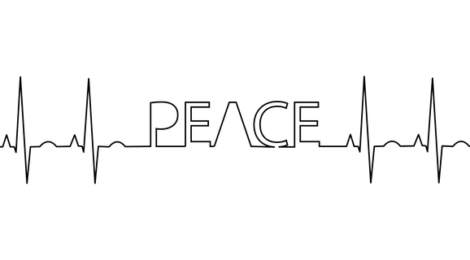
Quando il Nobel per la pace diventa poco pacifista
Il Nobel per la pace viene assegnato a persone che si sono distinte per la loro azione umanitaria e per la difesa dei diritti degli esseri umani. Nel tempo, però, alcuni destinatari di questo riconoscimento sembrano perdere la loro vena pacifista. Come nel caso di Abiy Ahmed Ali
Primo ministro etiope dal 2018 e vincitore del Nobel per la pace nel 2019 “per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Eppure, un anno dopo, le decisioni di Abiy Ahmed Ali non hanno propriamente mostrato un’inclinazione alla pace e al dialogo: ha ordinato l’inizio di un’offensiva militare contro le forze del Fronte di Liberazione Popolare del Tigrai (TPLF), nella parte settentrionale del Paese. Così la pace, a lungo cercata e poi trovata, con la vicina Eritrea potrebbe degenerare in una guerra civile.

Mettiamo un attimo in pausa la vicenda e scopriamo qualcosa sulla storia del Nobel per la pace. Come gli altri premi, è stato instituito nel 1895 dal testamento di Alfred Nobel e consegnato per la prima volta nel 1901. Questo premio, però, presenta delle differenze: non è consegnato in Svezia, ma in Norvegia nel Municipio di Oslo (perché nel 1901 la Norvegia era parte del Regno di Svezia e Norvegia) e il vincitore viene scelto da cinque persone del Parlamento che costituiscono il Comitato per il Nobel norvegese. Inoltre, può essere assegnato non solo a singoli individui, ma anche a organizzazioni, come, per esempio, nel 1917 al Comitato internazionale della Croce Rossa, nel 1954 e nel 1981 all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel 1999 a Medici senza frontiere e quest’anno, il 2020, al World Food Program delle Nazioni Unite.
In ben diciannove occasioni non è stato assegnato, e non meraviglia che siano tutte connesse a conflitti: durante la Prima e la Seconda guerra mondiale (dal 1914 al 1916, nel 1918 e dal 1939 al 1943), in alcuni anni tra le due guerre mondiali (1923, 1924, 1928, 1932), negli anni della guerra fredda (1948, 1955, 1956) e della guerra del Vietnam (1966, 1967, 1972). “Andrà alla persona che ha fatto il più possibile o del suo meglio per favorire la fraternità tra le nazioni, l’abolizione o la riduzione degli eserciti e per promuovere e mantenere la pace”. Così Alfred Nobel diceva nel suo testamento a proposito del Nobel della pace.Ma nel tempo alcuni vincitori sembrano tradire il significato di questo riconoscimento. E questo è quello che sembra stia accadendo con il premier etiope e che era già capitato con il Nobel per la pace del 1991, Aung San Suu Kyi.

By Claude TRUONG-NGOC – Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Nel 2017 ha avuto grande risonanza la vicenda, iniziata nel maggio 2012, relativa alle violenze subite dalla minoranza etnica dei Rohingya (popolo che viveva nello stato di Rakhine, nella parte settentrionale della Birmania), costretta alla fuga verso il confinante stato del Bangladesh. La leader birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace “per la sua lotta non violenta per la democrazia e i diritti umani” ha scelto di difendere lo stesso regime che aveva combattuto pur riconoscendo, di fronte alla corte dell’Aja (che giudica le controversie tra Stati), che “i militari del Paese potrebbero avere usato una forza sproporzionata a volte”.
L’opinione pubblica internazionale ha aspramente criticato la sua posizione, e le Nazioni Unite l’hanno accusata di essere “complice” dell’esercito birmano e indifferente nei confronti della minoranza mussulmana dei Rohingya. Il parlamento canadese, con voto unanime, a settembre del 2018 le ha revocato la cittadinanza onoraria. Ma la sua difesa dei militari le ha permesso di vincere le recenti elezioni perché i birmani vedono i Rohingya come una minaccia all’identità buddista del paese.
Torniamo ora in Etiopia e al suo primo ministro; anche qui sembra che ci sia stato un cambio di rotta con perdita della sua vena conciliante. Il premier sostiene che l’atto militare intrapreso sia una risposta a un presunto attacco del TPLF contro una base militare federale, nella capitale regionale di Macallè, ma le milizie respingono l’accusa sostenendo che sia solo un pretesto per giustificare l’impiego dell’esercito. Abiy Ahmed, a sua volta, risponde che l’uso della forza militare “ha come unico scopo quello di garantire pace e stabilità una volta per tutte”. Espressione molto discutibile, soprattutto se pronunciata dall’uomo i cui sforzi diplomatici avevano portato alla fine un conflitto con l’Eritrea che durava dal 1998.

By Mark Neyman / Government Press Office (Israel), CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
E nulla di fatto anche con l’offerta del presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, di usare il suo territorio per un incontro in campo neutro; Abiy Ahmed Ali ha rifiutato sostenendo di non voler incontrare quella che ritiene un’organizzazione terroristica.
Non si preannuncia dunque nulla di buono all’orizzonte, ma soprattutto nulla di buono viene da pensare osservando gli improvvisi cambi di atteggiamento di persone insignite del Nobel per la pace come Aung San Suu Kyi e Abiy Ahmed Ali. Persone che hanno combattuto usando le parole per affrontare le ingiustizie e le violazioni dei diritti e garantire la democrazia. Provando sulla loro stessa pelle gli effetti della mancanza di ogni forma di libertà. E ora come possono difendere e scegliere la violenza? O sminuirla o farla passare per uno strumento di pace? Soprattutto quello che non fa pensare a nulla di positivo è il fatto che sembrano aver dimenticato il problema più grave, cioè che quando si sceglie la via della forza, a pagare le conseguenze sono sempre quelli che andrebbero difesi.
Credits immagine in evidenza: Pixabay

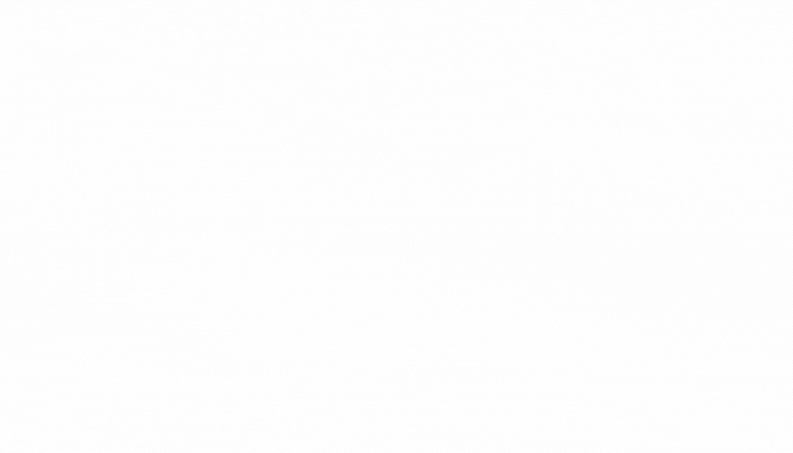
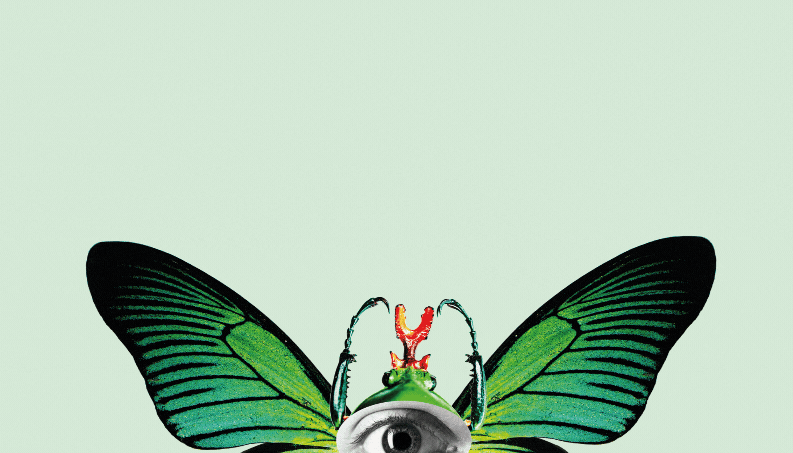



















Commenti recenti