
ricercatrici si diventa
Dall’Inghilterra all’Australia, dall’America all’Italia. Il percorso scientifico di Simona Giunta, professoressa associata presso il dipartimento di biologia e biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza università di Roma, vincitrice di un European Research Council Grant. Con lei parliamo di pubblicazioni scientifiche e di formazione, ma anche delle sue ultime due pubblicazioni sui centromeri e su un sistema per creare aneuploidia
la scienza è la vocazione più bella del mondo. Vai senza esitare!
Di che cosa si occupa la sua ricerca scientifica?
Sono una genetista e studio una delle regioni nel DNA umano di cui a livello genetico conosciamo meno. Considerando che la mappatura completa del genoma umano è stata completata nel 2002 quando negli Stati Uniti hanno concluso lo Human Genome Project, è interessante notare come nel 2023 ci siano ancora delle regioni più o meno oscure. Un passo avanti però c’è stato, infatti lo scorso anno un gruppo di ricercatori è riuscito a sequenziare l’intero genoma umano incluse queste regioni oscure di cui mi sono sempre occupata io. Per questo, oggi nel mio laboratorio ci occupiamo di studiare le sequenze ripetute, di come queste si mantengono stabili e di quali sono le peculiarità specifiche di queste regioni.
Qual è una scoperta che l’ha particolarmente emozionata?
Abbiamo avviato il mio laboratorio alla Sapienza circa due anni fa e devo dire che non ci siamo fermati un attimo, sono stati anni davvero intensi. Un lavoro di cui ci siamo occupati e che verrà pubblicato a breve riguarda il sequenziamento della linea cellulare diploide umana RPE1 (NdR cellula epiteliale del pigmento retinico). Questo è un traguardo molto emozionante per noi, perché ad oggi ci sono meno di cinquanta genomi umani pubblicati e che noi sappiamo nessuno da una linea cellulare di laboratorio. Quindi noi saremmo i primi a farlo.
un articolo per essere pubblicato su una rivista importante dal titolo alle figure non deve contenere errori e deve partire da un’idea scientifica innovativa
Che articoli avete pubblicato nell’ultimo anno? In particolare, sappiamo della sua ricerca su Cell, ce ne può parlare?
Abbiamo avuto due pubblicazioni. La prima è relativa a un lavoro interamente svolto dal nostro laboratorio, pubblicato su Molecular Biology of the Cell, una rivista dell’American Society for Cell Biology, nel quale io sono l’ultima autrice e la dottoranda Elena Di Tommaso è la prima autrice. La ricerca riguarda un progetto di microscopia a super risoluzione con cui abbiamo mostrato la struttura tridimensionale del centromero umano nei cromosomi mitotici. La pubblicazione su Cell è invece frutto di una collaborazione internazionale con Teresa Davoli, Assistant professor presso la New York University-NYU, che conosco da tempo perché lavoravamo entrambe alla Rockfeller University di New York, così come Nazario Bosco, il primo nome dell’articolo. L’idea di Teresa era creare un sistema per indurre aneuploidia a comando, quella che noi chiamiamo “aneuploidia fai da te”. Nel suo laboratorio sono riusciti a sviluppare questo sistema utilizzando una proteina mutata del cinetocore che, quando portata sullo specifico cromosoma, crea aneuploidia. Il piccolo contributo che abbiamo portato noi è stato valutare il danno che si viene a formare quando loro cercano di creare un’aneuploidia numerica. Ci ha lusingato essere coinvolti in un lavoro così importante e aver potuto dare degli input sia intellettuali, visto il nostro expertise con i centromeri umani, sia pratici, considerato che ci occupiamo di danno nelle sequenze ripetute. Con Teresa c’è una stima reciproca molto profonda a livello personale e professionale.
Che caratteristiche deve avere un paper che viene pubblicato su una rivista come Cell?
Sono veramente tanti gli aspetti da curare. Il primo è l’idea scientifica che deve essere nuova e innovativa, qualcosa che possa incidere davvero. Ci tengo molto a questo aspetto, infatti, lo insegno sempre alle scienziate che si stanno formando. Il secondo aspetto è far concretizzare velocemente l’idea di partenza e raccogliere i dati investendo tutte le energie del laboratorio. Poi il terzo aspetto è scrivere un articolo perfetto: dal titolo alle figure non ci deve essere nessun errore. Anche le figure dalla prima all’ultima devono essere curate nei dettagli e avere il layout grafico più recente. Questo potrebbe essere un problema: capita a volte di dover cambiare una figura perché è uscito un nuovo modo di farne. Essere considerati dall’editor richiede impegno e molto lavoro perché si tratta di esperti del tuo campo che vorranno trovare il pelo dell’uovo.
trovo un’aberrazione del sistema italiano doversi preoccupare del numero di pubblicazioni
Nell’era del publish or perish secondo lei qual è il giusto equilibrio tra il numero di pubblicazioni e la qualità?
Trovo un’aberrazione del sistema italiano doversi preoccuparsi del numero di pubblicazioni. Ho lavorato in tre continenti e non mi è mai successo che una scienziata si preoccupasse di questo. Nell’ambiente scientifico le preoccupazioni sono altre: innovazione, qualità dei dati, progresso e velocità. Non voglio aggiungere a queste la preoccupazione del numero di pubblicazioni. Anche perché avere tanti lavori non ti darà mai ad esempio un ERC (NdR European Research Council grant), che ti può dare invece l’innovazione. Vieni riconosciuta a livello internazionale quando lavori in un campo di ricerca nuovo come mi è successo quando lavoravo sull’instabilità genomica di sequenze non ancora sequenziate. Secondo me servono altri modi per vedere se la ricerca che sto facendo ha valore, tra questi considerare le citazioni ed escludere le autocitazioni. Per esempio, mi ha dato molta soddisfazione il tweet di un laboratorio che, a proposito di un mio protocollo, diceva: “quando una scienziata pubblica un protocollo così ben descritto tu lo fai per la prima volta e ti trovi i cromosomi perfetti”. Io farei contare anche questo; non a caso alcuni giornali hanno adottato la metrica di social media coverage.
secondo me dobbiamo separare due cose: la formazione didattica che è fondamentale e la ricerca di ultima frontiera
Le pubblicazioni incidono anche sui finanziamenti che vengono erogati. In questo caso secondo lei come sarebbe giusto contarli?
C’è questa idea che dobbiamo dare pochi fondi a tanti gruppi. Mi viene spontaneo pensare “per fare cosa?”. Secondo me dobbiamo separare la formazione didattica, che è fondamentale, e la ricerca di ultima frontiera. Quindi ci possono essere dei laboratori che scelgono di puntare sulla formazione, per cui si prendono tante studentesse e dottorande e pubblicano articoli costruiti per far crescere le scienziate del futuro, che non si possono valutare sul numero di pubblicazioni o citazioni. Poi ci possono essere laboratori o istituti che svolgono ricerca di avanguardia tutelando anche i PI dal fare troppa formazione accademica, che può distrarre. Costruire tanti laboratori che fanno piccola ricerca incrementale crea quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni: un’esplosione di pubblicazioni in cui voi giovani non riuscite più a navigare e in cui diventa difficile distinguere la ricerca di alta qualità. Quindi secondo me è necessaria una separazione tra questi due tipi di laboratorio affinché vengano dati a ciascuno distintamente i fondi, gli strumenti e gli spazi adeguati.
Ci sono delle buone pratiche che si è portata in Italia dalla sua esperienza all’estero?
Mi sono laureata a Londra, dottorata all’università di Cambridge, ho lavorato in Australia e poi mi sono trasferita a New York dove ho lavorato dieci anni presso la Rockfeller University, un’eccellenza di ricerca mondiale dove ho vissuto tre premi Nobel. Quindi devo dire che tanto del modo in cui faccio ricerca lo devo alla mia formazione di New York. La mia famiglia e la mia mentalità sono al cento per cento newyorkesi. Infatti, per me sono molto importanti la libertà, la diversità e la multiculturalità, e la mia ricerca riflette questo.
Gli Stati Uniti le hanno dato una grinta diversa sul lavoro?
Sicuramente mi hanno dato un’impostazione diversa. Mi piace la parola grinta perché a New York ti fanno pensare che tutto è possibile e questo dà molta fiducia. Cambiare l’approccio mentale cambia la società e cambia la qualità della vita. A Roma ci focalizziamo molto sugli aspetti negativi, invece dovremo essere più propositivi come negli Stati Uniti. Nella mia ricerca cerco di trasmettere a chi lavora con me questo concetto di fiducia: i giovani sono la nuova frontiera che faranno la differenza.
Secondo lei è necessaria l’esperienza all’estero?
Io rifiuto l’idea italiana che le mie studentesse non possano passare tutta la loro vita all’interno della Sapienza, perché se il tuo modo di fare ricerca è internazionale questo ti rende una scienziata del mondo e ciò basta per una grandissima carriera. Andare all’estero è un’esigenza di crescita personale, ad esempio per imparare una tecnica o creare collaborazioni, non è un obbligo senza il quale vali meno come scienziata. La scienza ha bisogno di “scienziate del mondo”, ma spostarsi fisicamente anche se può dare un vantaggio non è necessario se comunque c’è uno scambio internazionale e collaborazioni. Pensare che la ricerca in Italia non si possa fare e che è necessario scappare secondo me è molto sbagliato, perché l’eccellenza si può fare anche qua.
andare all’estero è un’esigenza di crescita personale e non un obbligo senza il quale vali meno come scienziata
Come è stato tornare in Italia?
Sono stata reclutata in Italia, ma ci ho pensato molto prima di decidere di rientrare, perché con una famiglia di New York temevo lo shock culturale. Mi sono però resa conto che questo shock è fittizio, appartiene a una società che vuole rimanere indietro e che vuole dipingersi e rappresentarsi per quello che non è. Infatti, passeggiando nella città universitaria della Sapienza sembra già di stare a New York.
Dove si immagina tra cinque anni?
Oggi sto lavorando sulle fondamenta. Tra cinque anni mi vedo ad aver contribuito al campo di ricerca che, diciamo, un po’ mi fregio di aver avviato. Vorrei arrivare a un setup tecnico per cui queste regioni non saranno più un problema e potranno essere analizzate e consultate per qualsiasi domanda biologica e aver quindi capito, sviscerato e risolto le questioni che studiamo oggi.
Nel suo discorso al dipartimento di biologia e biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza in occasione della vincita dell’ERC grant ha parlato della sindrome dell’impostore. Che cosa intendeva?
È la cosa che ci troviamo a gestire più spesso nell’ambiente accademico e nella crescita personale, soprattutto del genere femminile. È un processo cognitivo all’interno di un percorso di crescita personale che però va identificato e risolto, perché non possiamo portarci dietro questa vocina che ci dice costantemente “non sei all’altezza, non sei adeguata, sei fuori contesto e non ti meriti di essere dove sei, ci sei capitata per caso”. Quando sono arrivata a Cambridge, veramente pensavo avessero fatto un errore sebbene avessi avuto molti successi accademici. Durante il discorso di apertura del corso il Master del college ci ha detto “so che pensate di essere qui perché abbiamo fatto un errore ma non è così, ognuno di voi è stato scelto, qua non facciamo errori”. Ciò mi ha portato a identificare la sindrome dell’impostore e ho iniziato a fare di quella energia, che potrebbe essere negativa e inibitoria, un motore per crescere: l’ostacolo è la strada e io posso saltarlo.
Un consiglio a una giovane ricercatrice?
La scienza è tutta la mia vita. Dico che è la vocazione più bella del mondo e che ti riempie in tutto e per tutto. Quindi vai senza esitare!
Simona Giunta, biologa e professoressa associata presso il dipartimento di biologia e biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza università di Roma
Sofia Gaudioso, biologa e comunicatrice della scienza, Sapienza università di Roma

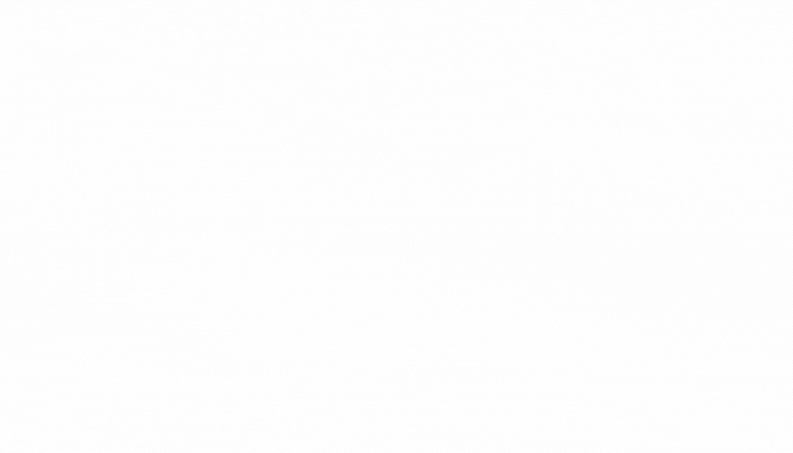
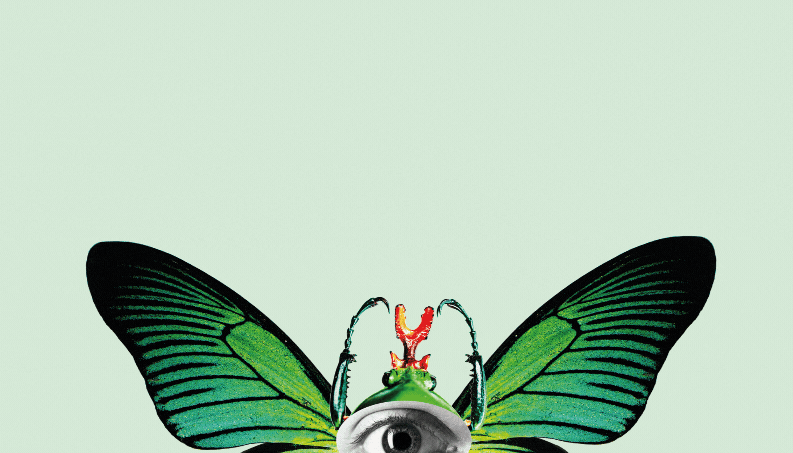


















Commenti recenti